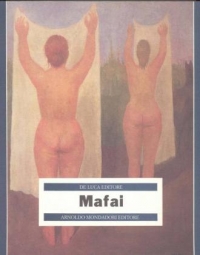Saggio: Flaminio Gualdoni
Estratto
Quando, nel 1943, Santangelo pubblica per le Edizioni della Galleria della Spiga e di Corrente il volumetto dedicato a Mafai nei “Quaderni del disegno contemporaneo” , l’artista è nel pieno di uno dei più complessi e sottili “slittamenti programmatici” tra quanti caratterizzano la lunga sua vicenda tra guerra e dopoguerra.
Egli vive una crisi. Crisi che non è debito di stimoli, o calo di tensione stilistica, o squilibrio improvvisamente aggallato di mezzi: che scaturisce dal collidere silenzioso ma drammatico tra le ragioni tutte esterne del suo essere nella pittura e il lavorio ossessivo, interno, irrelabile, di una coscienza che sa la propria irrevocabile estraneità storica. A quarant'anni, tra Genova e Roma, egli è già certificato maestro. La consanguineità con Scipione, via Cavour mitizzata, Demolazioni e Fantasie erette, bon gré mal gré, a stendardi della moralità indignata dei tempi, e a prodromi di quell'arte "nazionale e popolare", sinergia di tensioni politiche e civili, che farà la cultura nuova, sono i segni macroscopici del suo consistere come figura pubblica, riferimento e modello necessario d'una generazione.
(.....)
Tant'è. C'è urgenza di realtà, di storia, e cronache, e castelletti retorici di nuovi discorsi, d'un sentirsi vivere tutto specchiato nelle parvenze del vivere per qualcosa. Che Mafai concepisca il fare, l'indignazione stessa, come il proprio fare, come la propria indignazione, come separatezza renitente a ogni esemplarità, a ogni confrérie ecclesiale, in fondo poco importa. Che abbia rinunciato a invader l'Italia col veleno dolce dei suoi fiori per tentare la singolarità irripetibile dell'immagine estrema, per uscire definitivamente dal marasma dei nutrimenti terrestri, e non per seguire basculando le querelles tra gli apologeti provinciali del formalismo e i loro simmetrici del realismo – con l'incubante terza via astratto-concreta – conta ancor meno. A lui, vocato al mormorio solitario, al laicismo da ogni verbo, si chiede d'essere maestro di parole chiare, e univoche, che tengano il passo delle fragorose ecolalie critico-ideologiche. Egli però continua a mormorare, a coltivar dubbi in luogo di speranze, ergo, si proclama, è in crisi, né gli tocca l'aeropago dei consacrati, ma l'umiliazione di chieder continua venia alla mediocrazia.
(....)
Mafai si tiene ancorato al paesaggio, alla figura, alla natura morta, ma sacrificando il motivo, il lievito sentimentale che pur sempre risuona nelle sue pitture. Le periferie, le vedute di Fiumicino, così come i fiori i barattoli i peperoncini, divengono costrutti elementari, strutturalmente elusivi, ritrovano la propria scala di valori nello scambiarsi magro e risentito dei toni, nella luce salda e senza splendori che ne imbeve i rapporti e li rende evidenza semplice, appena concedendosi soprassalti di rosso, di viola, nella tonalità minore degli azzurri imbigiti, degli ocra deperiti a terra spenta. Le pennellate si poggiano brevi, come timorose del guizzo di grazia, macerano il colore anziché eccitarlo, sfibrano la materia in rinunce continue, in temperature rattenute, in emozioni filtrate e meditate fino all'estraneità. Certo, è pur vero che questo che dipinge è un Mafai preoccupato, così ansioso di controllo sul processo pittorico e così assediato dalla scelta di essere uomo di verità – per quanto consapevolmente illusoria, perdente – piuttosto che bizantino uomo di parola schierato su l'una o l'altra barricata, ma contemporaneamente in coscienza presente ai tempi, da rattrappire l'estensione naturale, fisiologica direi, dei suoi raggiungimenti e possibilità, in una sorta di continua autocertificazione di rigore.
Proprio in questo tempo, il giovane Scialoja gli dirige un'esortazíone assai sintomatica: "Diffida dai garzoncelli petulanti che si permettono starti alla pari, non far coro nel rinnegare e spregiare i tuoi simbolici fiori secchi. Scava, approfondisci, arricchisci nella tua direzione, sii fedele a te stesso, al tuo dolore. Decidi di non esser popolare nelle brigate turbolente o sugli sgrammaticati giornaletti d'avanguardia. Fatti superare dai tempi, ma rendi sempre più solenne il tuo tempo interno; non esser contemporaneo ma sii contemporaneo a te stesso, fatti pure trascinare dalla cronaca piuttosto che comportarti con essa in modo subdolo e affascinato, come il vecchione con Susanna. Guarda d'essere inattuale, di apparire in ritardo, addirittura sepolto". Non con l'attualità si gioca la partita di Mafai, ma con il tempo. Il suo purismo è come si misurasse continuamente con il fantasma ostinato e digrignante dell'ultimo Cézanne, eretto in lui a grande modello della vocazione definitiva al silenzio, all'alterità.
(...)
Nel clamore scandalistico della mostra alla Tartaruga del '59, tra rifiuti e cooptazioni facinorose, tra gongolii e ripulse di critici che ancora pretendono d'elargire medaglie, Mafai ritrova senso e respiro di quel limite sottile, di bruciante angoscia, che era stato – questo sì, pienamente, seppur in altre fattezze – delle allucinate tensioni iniziali. Sente finalmente correre nei propri nervi, nelle proprie vene pulsanti, la cupa felicità finale del suo Cézanne, del suo Greco, del suo Tiziano. Certo, gli altri parlano di Wols e Tobey, compagni dell'ultima Biennale, e di Pollock e De Staël – qualcuno, più acuto, di Gorky –, monumenti di dispersione eroica, esemplari sconfitti. Certo, pur nel suo voler essere marginale, né eroe né esempio, Mafai li guarda: anch'essi hanno un'intensità da offrire, imprigionata in quei totem franati. Ma lui non è uomo di simboli, o allusioni; soprattutto è disincantato al fare per energia attiva. Il suo è un avvertirsi vivere, non un sentirsi vivo; senza aperture prospettabili. Rinascere, Pensieri inutili. I gesti sono brevi, contratti, come crampi senza pulsioni che si alzano su un fondo più disteso e zonato, come nuclei grumosi che lievitano irritati a misurare una profondità, a moltiplicarsi evitando il rischio banale delle due dimensioni, dell'ultimo sospetto decorativo. I bordi chiudono ancora, in una ritrovata tensione centripeta: non sono convenzioni: l'opera, tutta, è la stremata esperienza. Cancellare la mernoria. I reticoli, semplici blu gialli rossi, si serrano fittissimi a occludere lo spazio, a pressarlo, in una crescita che non è regola ma annaspare saturando, per toni disagiati, per elisioni continue.